L’intelligenza artificiale sta rapidamente trasformando il settore giuridico e professionale, ma il suo utilizzo non è privo di perplessità: un caso significativo riguarda il fenomeno delle cosiddette “allucinazioni” dell’IA, ossia la generazione di dati errati o di sentenze inesistenti presentate come veritiere. L’ordinanza del Tribunale ordinario di Firenze (sezione imprese, 14 marzo 2025) ha recentemente offerto un’importante occasione per analizzare le responsabilità legali derivanti dall’impiego di strumenti basati su IA, con particolare attenzione all’art. 96 del codice di procedura civile (c.p.c.), che disciplina l’abuso del processo e la responsabilità aggravata.
Nel caso in esame, nello specifico, un avvocato ha presentato riferimenti giurisprudenziali inesistenti generati da ChatGPT. La difesa ha, in seguito, affermato che tali citazioni derivavano da una ricerca effettuata da una collaboratrice di studio, senza che il difensore fosse a conoscenza dell’origine dei dati. Il fenomeno delle allucinazioni dell’IA si manifesta quando il modello di intelligenza artificiale produce informazioni errate ma apparentemente coerenti, rendendole difficili da distinguere da dati autentici e ciò solleva il problema della responsabilità per la presentazione di atti contenenti riferimenti inesatti. In tal senso, l’art. 96 c.p.c. prevede la responsabilità processuale aggravata, sanzionando chi agisce o resiste in giudizio con dolo o colpa grave, arrecando danno all’altra parte. Nonostante tutto, il Tribunale di Firenze ha ritenuto che, nel caso specifico, l’errore derivante dall’uso di ChatGPT non fosse riconducibile a un intento fraudolento o doloso e la citazione giurisprudenziale inesistente è stata inserita per rafforzare un’argomentazione difensiva già delineata e non con l’intento di resistere in giudizio in mala fede: conseguentemente il Tribunale ha escluso l’applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 96 c.p.c.
Il caso in questione pone interrogativi fondamentali sull’uso responsabile dell’IA in ambito legale: se da un lato l’IA rappresenta un valido strumento di supporto per i professionisti del diritto, dall’altro il suo impiego richiede un controllo umano attento ed appare quindi essenziale adottare protocolli chiari per la verifica delle informazioni fornite, al fine di evitare errori che possano compromettere la credibilità e l’efficacia dell’argomentazione giuridica. In definitiva, la responsabilità non può essere attribuita all’IA in sé, ma a chi la utilizza senza un’adeguata verifica delle fonti. In considerazione degli elementi emersi, l’ordinanza impugnata viene parzialmente modificata, confermando e ampliando le misure a tutela del reclamante.
Dunque, la questione riguarda una controversia legale in cui un ricorrente, titolare di un marchio italiano e autore di una serie di vignette satiriche, ha denunciato l’uso non autorizzato delle sue opere su t-shirt prodotte e vendute da una terza parte. Il marchio del ricorrente rappresenta un carrello della spesa stilizzato, e le sue vignette erano state stampate su t-shirt, alcune con il marchio e altre senza, vendute attraverso rivenditori. Il ricorrente ha presentato una serie di richieste, tra cui il sequestro dei prodotti contraffatti, la distruzione degli stessi, l’inibizione alla continuazione dell’attività illecita e la pubblicazione del provvedimento. Il giudice di primo grado ha accolto alcune delle richieste, autorizzando il sequestro dei prodotti e la descrizione delle t-shirt coinvolte, ma ha rigettato altre richieste, come quelle nei confronti di alcuni rivenditori che non si erano costituiti in giudizio. Il reclamante ha successivamente presentato un reclamo, chiedendo l’estensione delle misure cautelari anche ai rivenditori contumaci e sollevando vari punti, tra cui la violazione del diritto d’autore e del marchio, e la necessità di estendere le sanzioni a tutti i soggetti coinvolti nella commercializzazione dei prodotti contraffatti, indipendentemente dalla loro buona fede.
In fase di reclamo, il giudice ha esaminato i requisiti per la concessione delle misure cautelari, in particolare il fumus boni iuris (la probabilità che il diritto rivendicato sia valido) e il periculum in mora (il rischio di danno irreparabile per il reclamante). La violazione del diritto d’autore e del marchio è stata riconosciuta, con particolare attenzione alle magliette che riproducevano non solo le vignette, ma anche il marchio registrato del reclamante. Si è ritenuto che la riproduzione non autorizzata del marchio costituisse contraffazione, mentre l’uso delle vignette sui prodotti venduti dai rivenditori contumaci è stato ritenuto un atto di plagio ed è stato ribadito che, secondo la giurisprudenza consolidata, anche i rivenditori possono essere ritenuti responsabili della violazione dei diritti d’autore, poiché hanno contribuito alla distribuzione dei prodotti contraffatti.
Dunque, la corte ha ritenuto legittima la richiesta di estensione delle misure cautelari a tutti i soggetti coinvolti nella distribuzione delle magliette, con particolare attenzione al danno subito dal ricorrente, che si sarebbe visto pregiudicare la sua possibilità di ristoro a causa della continuazione dell’attività illecita ed ha rigettato la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. Non sono stati dimostrati danni causati da tale errore. Per quanto riguarda le spese legali, i reclamati sono stati condannati a rimborsare le spese sostenute dal reclamante, che sono state liquidate in base ai parametri di legge.
In definitiva, la vicenda ha sollevato importanti riflessioni sul ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nel settore legale. Sebbene l’uso di AI possa velocizzare la ricerca giurisprudenziale, vi sono dei rischi legati all’affidabilità dei risultati generati, che possono condurre a errori significativi, come la citazione di sentenze inesistenti: malgrado l’intenzione di non agire in mala fede, l’errore evidenzia un punto importante, ossia responsabilità di chi si affida a tali strumenti. È quindi essenziale che l’utilizzo nel campo giuridico avvenga con prudenza e attenzione, al fine di evitare conseguenze per l’integrità del sistema giudiziario nel suo complesso.


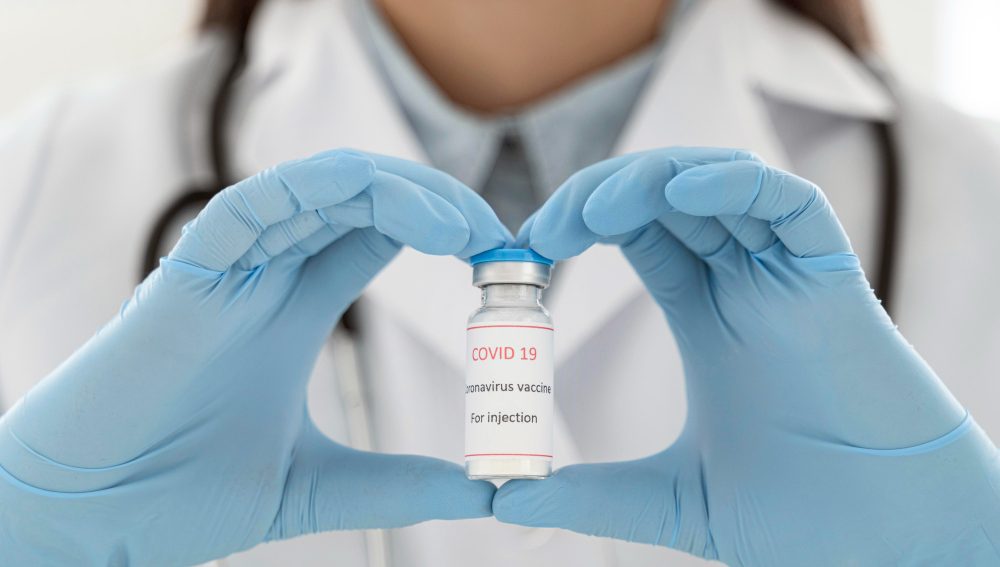




Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.